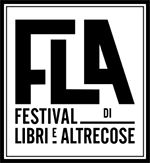Le cose di dopo
Il Contest del FLA2020
SPAZI DA COLORARE
di Liliana Mianulli
Credevo di conoscere ogni piccola parte di me e ogni angolo di quella via.
Credevo di aver visto qualunque sfumatura possibile in quello scorcio di cielo e di riuscire a riconoscerne i colori anche al buio.
Ma non era più così. Nulla era più come prima. Nemmeno io.
A breve sarebbe arrivato l’ennesimo giorno di quell’assurdo non-anno: un giorno infinito vissuto mille volte, registrato su una vecchia VHS, che gira a una velocità talmente diversa dal resto, che è come se non esistesse affatto.
Una specie di ricordo infilato in un cartone, sul cui bordo c’è scritto con il pennarello nero e a grandi lettere: “Cose varie”.
Ogni mattina uscivo per la mia manciata di chilometri da dare in pasto alle gambe allenate: ma non quel giorno. Avrei camminato e nemmeno a passo spedito, ma lentamente, come se ognuno di quei passi fosse l’ultimo, quello che vuoi goderti fino in fondo, in ogni piccolo movimento, in ogni battito che riesci a distinguere e ti rimbomba nel ventre affranto.
Attraversai la strada affollata solo dai miei pensieri e, in pochi istanti, mi ritrovai sul lungomare. Camminavo sfiorando la ringhiera di acciaio, in teoria liscissima e fredda, ma resa incandescente dal passaggio desolato delle mie dita ansiose: solo quelle non riuscivo a tenere a bada, forse per incostanza o magari solo per paura.
Il mare ancora confuso con la notte all’orizzonte e stordito, come me, da quel turbinio di emozioni.
Mi sentivo come un bambino a una festa di paese, con il palloncino a forma di cuore rosso brillante, in mezzo a una folla di estranei, alla disperata ricerca dello sguardo rassicurante che non vede più.
A pochi passi, il cartellone dei manifesti mortuari: anche quello dei miei era finito lì, sulla carta fotografica a colori.
E io, avvilito, avevo guardato impotente l’addio del mio bel palloncino finito chissà dove pure lui.
Li conoscevo quasi tutti quei volti: mi avevano visto crescere in quella strada, un tempo brulla e vociferante, con le ginocchia sbucciate e i capelli spiaccicati dal sudore estivo.
Erano andati via in un soffio, lo stesso soffio che era venuto a mancare nell’eco di una vita che non sarebbe mai stata più la stessa.
Probabilmente per nessuno di noi, probabilmente in nessun angolo remoto del mondo.
Un leggero maestrale solleticava l’angolo di un manifesto che cominciò a svolazzare velocemente e, alzando il bavero, mi poggiai alla ringhiera e fissai un punto nel centro dove, da bambino, avrei tirato una bella linea netta a dividere cielo e mare, con gli immancabili spazi vuoti, in cui infilarci segreti e speranze.
Guardavo quell’oltre deformato dal pensiero incompiuto di me bambino e aspettavo l’alba ogni mattina, pazientemente.
Avevo vissuto sempre di corsa, con l’agenda serrata, i promemoria sul cellulare, l’orologio ultra-tech che suonava ogni mezzora per ricordarmi che la vita scorreva e io ero in ritardo come al solito.
Ma non era più così. Nulla era più come prima. Nemmeno io.
Gli aerei si erano impolverati, il passaporto fermo a un lontanissimo weekend dalle camicie leggere e i calzoni corti e io avevo perso i miei genitori in poco più di un mese. Ero riuscito a salutare solo mia madre, un istante, da lontano e senza poterla neanche baciare per l’ultima volta, prima di vederla andar via con l’ambulanza.
Ero arrivato 10 minuti prima del previsto, ma in ritardo. Come al solito.
Nonostante le sveglie, i promemoria e tutto il resto.
Ero rimasto con le mie gambe toniche, sempre di corsa, al centro di quella stessa strada, con la borsetta di vernice nera con le sue pillole, le chiavi di casa e il suo tipico fazzoletto di cotone ricamato.
Poche ore dopo, su quel cartellone di alluminio, avevano messo la sua fotografia che, senza volerlo, aveva coperto quella di mio padre, anche se solo per metà. Riuscivo ancora a leggerne in parte la frase di saluto. Per lui no, ero arrivato troppo tardi: avevamo smesso di parlarci due anni prima per una conversazione dai toni accesi che nemmeno riuscivo a ricordare.
Non ero riuscito a salutare l’uomo che mi aveva insegnato ad andare in bici e mi aveva tenuto per mano milioni di volte, per delle parole dette che avevo anche dimenticato.
E questo, se possibile, faceva ancora più male.
Ci tenevo un sacco a certe sciocchezze un tempo: come le prese di posizione, la perfezione e la puntualità.
Ma non era più così. Nulla era più come prima. Nemmeno io.
Solo che nel frattempo loro due se n’erano andati e io ero ancora lì.
Mi mancavano, ma non sapevo a chi dirlo.
E mi veniva anche da piangere, ma non sapevo cosa farci con tutte quelle lacrime che erano un passo indietro ai miei sensi di colpa e alle mille frasi inutili, che iniziavano tutte con terribili “se”.
Così, nell’attesa di ritrovare la forza di essere di nuovo bambino, fissavo quella linea che avrei tirato sul cartoncino, sperando che quel dolore riempisse gli spazi vuoti che non ero riuscito a colorare e che, in qualche modo, potessero bastare a sostenere quel silenzio atroce.
Qualcuno si fermò accanto a me: un’altra anima disperata. Si stringeva in un cappotto scuro, avvolta in una sciarpa a fiori, gli occhi chiari arrossati forse dal vento, forse da qualche assenza. Ci guardammo e lei mi sorrise: con una dolcezza a cui non ero davvero abituato e l’espressione di chi ha già imparato a sporcarsi di nuovo le mani con i colori.
Ricambiai frastornato: mi sarei aspettato qualunque cosa in quel momento, ma davvero non quel regalo improvviso.
Restammo così: due sconosciuti a fissare il futuro, nella sua straordinaria normalità, tratteggiato con pennarelli di un azzurro nuovo, profondo come un abbraccio che non hai dato in tempo e fiducioso come il mare, che dopo la tempesta, torna sulla riva a raccontare quello che ha imparato dai suoi viaggi.
Guardai il mio polso privo di orologio e sorrisi ancora: forse, per la prima volta nella mia vita, ero ancora in tempo.
Registrati o fai il login per votare!